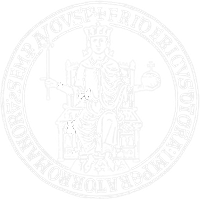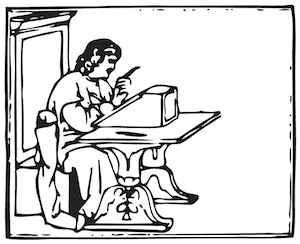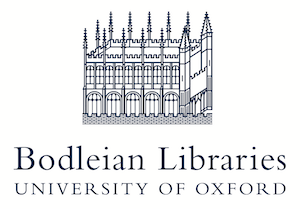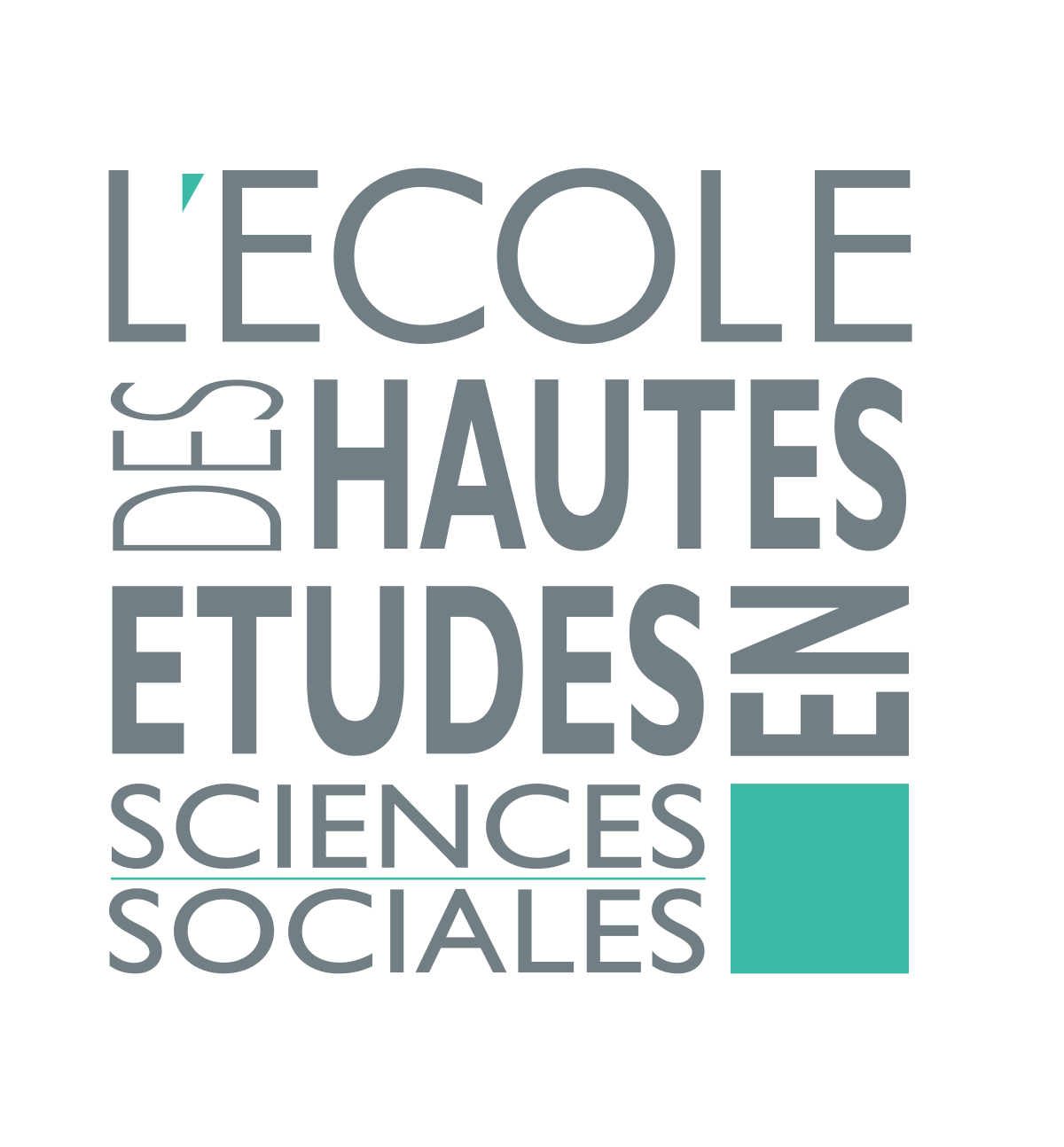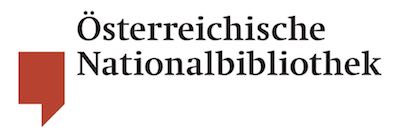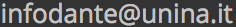Paris, Bibliothèque nationale de France; Manuscrits, 2017
Permalink:
IIIF manifest:
CNMD/0000279857 Roddewig/574 CCD/564
Manoscritto membranaceo, guardie cartacee; sec. XV, 2° quarto, data stimata (Termine ante quem: 1438 ex., desumibile da una lettera di Barzizza dell'agosto 1438, in cui dichiara di essere immerso «in profundum Inferni», riferendosi probabilmente all'attività di esegesi degli ultimi canti dell'Inferno. Termine ante quem: 1447, anno di morte del dedicatario Filippo Maria Visconti.); Milano; cc. + 381 + ; numerazione moderna in inchiostro, in cifre arabiche nel margine superiore esterno alle cc. 1-381, con salto da cc. 203 a 205 e da cc. 335 a 345; tracce occasionali (ma pressoché sistematiche da c. 326 in avanti) di numerazione piú antica in cifre arabiche.
Stato di conservazione: buono.
Dimensioni: mm 315 x 220. Taglia: 535 (medio-piccola). Proporzione: 0.7.
Fascicolazione: 1/8, 2/4, 3/6, 4/8, 5/6, 6/7, 7/8, 8/7, 9-13/8, 14/7, 15/5, 16/8, 17/5, 18/8, 19/6, 20/8, 21/6, 22/7, 23/8, 24/6, 25-27/8, 28/7, 29-35/8, 36/7, 37/5, 38/7, 39/5, 40-42/8, 43/6, 44-48/8, 49/7, 50-51/8. Al fascicolo 1 è stata sottratta una carta e in seguito aggiunta un'altra (c. A) (orig. quaternione). I fascicoli 6, 8, 14, 22, 28, 36, 38, 49 sono mutili di una carta (orig. quaternioni); i fascicoli 3, 5, 19 sono mutili di due carte (orig. quaternioni); i fascicoli 15, 17, 37, 39 sono mutili di una carta (orig. ternioni), il fascicolo 2 è mutilo di due carte (orig. ternione). . Fascicolo prevalente: 4 bifogli (quaternione).
Righe: rr. 43 / ll. 42.
Tecnica di rigatura: a mina di piombo.
Disposizione del testo: a piena pagina.
Richiami: al centro del margine inferiore.
Tipologia grafica: Mano 1: littera textualis (Inferno e commento, cc. 1r-381v); Mano 2: corsiva umanistica (integrazioni di terzine omesse dalla mano principale, cc. 53r, 304v, 311r); Mano 3: corsiva (integrazione di versi illeggibili per taglio trasversale della carta, c. 372r-v).
Storia del manoscritto: Manca la sottoscrizione del copista. Il codice è stato realizzato per il duca di Milano Filippo Maria Visconti, verosimilmente sul finire del quarto decennio del secolo XV. Esso reca a c. 16v una nota di possesso seicentesca di Henry Victor de Cardaillac, maresciallo e camerario di Luigi XIII, che nel 1645 fu creato barone e marchese di alcuni centri oggi situati nel dipartimento del Lot. Il codice era appartenuto in precedenza ad Antoine e François de Cardaillac, rispettivamente nonno e padre di Henry Victor: ad Antoine, cavaliere dell’Ordine del Re e siniscalco di Quercy, il manoscritto era pervenuto in dote da Vittoria d’Aquino, figlia di Antonio d’Aquino, la quale ne era a sua volta venuta in possesso tramite la madre Isabella Caracciolo, che lo aveva ricevuto in dono dal padre Giovanni (1487-1550), principe di Melfi e maresciallo di Francia alla corte di Francesco I, ultimo nome a cui la nota a c. 16v consenta di risalire. Caracciolo potrebbe essersi procurato il codice durante una delle campagne militari condotte in veste di luogotenente di Francesco I in Lombardia, dal 1499 teatro di scontri tra Valois e Asburgo a causa del vuoto di potere provocato dal tracollo sforzesco, ma è anche possibile che lo ricevesse in dono dal suo sovrano per i servigi resi in area italiana. Il codice fu rinvenuto da Gaston de Flotte nel 1835 in un castello della Dordogna (da identificare con ogni probabilità con il Castello di Lacapelle-Marival, storica residenza dei Cardaillac), in pessimo stato di conservazione, e affidato all'avvocato imolese Giuseppe Zacheroni, resosi responsabile dell'asportazione di almeno 21 carte, di cui alcune miniate, confluite attualmente in Imola, Biblioteca comunale, ms. 76. A c. Ar, successiva al foglio di guardia anteriore, si trovano due note: la prima, ottocentesca, in francese, forse di Gaston de Flotte, è tratta dal catalogo di de Bure ed è in realtà un'erronea identificazione del codice, dal momento che la descrizione corrisponde a Paris, Bibliothèque nationale de France, It. 1469, testimone realizzato per Francesco I; la seconda nota, in basso a sinistra, datata al giugno 1887, segnala corrispondenza tra la nota e la scheda del catalogo; la terza, in basso a destra, a lapis, rimanda al numero della «Gazette du Midi» del 29 marzo 1838, in cui de Flotte rese noto il ritrovamento del codice. Timbri della Bibliothèque nationale de France alle cc. 1r, 380v, 381v, in inchiostro rosso.
Nomi legati alla storia: Visconti, Filippo Maria duca di Milano <1392-1447>. Maestro delle Vitae Imperatorum <sec. 15.>.
Data di entrata in biblioteca: 1887.
Osservazioni:
Scrittura e mani: Mano 1: inchiostro bruno, progetto originario; Mano 2: inchiostro bruno, aggiunta a progetto originario; Mano 3: inchiostro bruno, aggiunta a progetto originario.
Scrittura e mani: Mano 1: inchiostro bruno, progetto originario; Mano 2: inchiostro bruno, aggiunta a progetto originario; Mano 3: inchiostro bruno, aggiunta a progetto originario.
Descrizione interna
cc. 1r-2v: Lettera prefatoria a Iacopo da Abbiate
Autore: Barzizza, Guiniforte <1406-1463>.
Titolo elaborato: Prefatoria a Iacopo da Abbiate.
Incipit (Intitolazione): [...] lateri assistas eandem sibi facie (c. 1r).
Explicit (Finit): protectione humiliter ac devotissime consecrat (c. 2v).
Explicit (Finit): protectione humiliter ac devotissime consecrat (c. 2v).
cc. 3r-381v: Commento all'Inferno
Autore: Alighieri, Dante <1265-1321>.
Altri nomi: Barzizza, Guiniforte <1406-1463>, commentatore.
Titolo elaborato: Commento all'Inferno.
Incipit (Intitolazione): Si nui volemo considerar ben la condicione (c. 3r).
Explicit (Finit): [...] (c. 381v).
Explicit (Finit): [...] (c. 381v).
Rubriche: volgari (lunghe).
Decorazione
Progetto decorativo unitario. Progetto completo.
Descrizione generale: Il progetto decorativo, originariamente completo, è pervenuto solo parzialmente a causa dell'asportazione di carte o lacerti di pergamena miniati.
Iniziali ornamentali: filigranate, ornate foliate.
Attribuzione: Illustratore: della bottega di Magister Vitae Imperatorum (attribuito). Origine: Milano. Datazione: 1430 - 1440.
c. 6r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante smarrito nella selva.
Macrosoggetto: Dante nella selva.
Parole chiave: Dante / Dante spaventato / paura / selva / fiume / alberi / rocce / colle / buio.
Rapporto testo-immagine: Inferno I 1-12.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: Selva.
Rapporti con la tradizione dantesca: Da segnalare la presenza di un dato non citato nel testo e che si presenta in tutte le miniature relative al primo canto: un fiume, che sembra scorrere parallelamente alla selva e scompare dietro al monte «ch’è principio e cagion di tutta gioia». Tale elemento si riscontra altrove nella tradizione iconografica della Commedia, in codici quali Firenze, BR, 1023 e BNCF, Banco Rari 215; Paris, BnF, It. 74 e It. 78 .
Note: La posa del protagonista con entrambe le mani alzate e i palmi rivolti verso l’esterno, insieme all’espressione contrita del volto, suggeriscono il sentimento di paura che pervade l’intero canto. Il fondale in nero, attraversato da linee ondulate, può rappresentare, oltre alla canonica oscurità del luogo – che nelle altre miniature del canto I, alle carte successive, si diraderà progressivamente grazie alla comparsa del sole –, l’aria putrida dell’ambiente infernale. Sembra rilevante, inoltre, il fatto che ogni albero sia rappresentato con minuzia di particolari, permettendo di distinguere tipi diversi di fogliame: tale scelta potrebbe plausibilmente concordare con un passaggio dell’esposizione morale di Barzizza, in cui agli uomini che non sempre tendono al bene, ma sono spesso sviati da una varietà di vizi e desideri, viene accostata l’immagine di una selva in cui si trova «grande varietà de arbori».
c. 10r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: La lonza e il leone impediscono il cammino di Dante.
Macrosoggetto: Tre fiere / Dante nella selva.
Parole chiave: Dante / selva / alberi / colle / lonza / Leone / alba / paura / pianeta / Sole / fiume / rocce / raggi luminosi.
Rapporto testo-immagine: Inferno I 31-48.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: Selva.
Rapporti extra-danteschi: La rappresentazione di animali quali la lonza e il leone è presente anche in altri codici attribuiti al Magister Vitae Imperatorum: nel breviario per Maria di Savoia, il ms. 4 della Bibliothèque Municipale de Chambéry, alle cc. 319v e 511r incontriamo due leopardi molto simili a quello rappresentato nell’It. 2017; in particolare, il primo risulta quasi identico anche nella posa: entrambi, infatti, non guardano davanti a sé, ma sembrano rivolgersi indietro torcendo il collo. Anche per il leone è possibile stabilire un confronto con un codice di mano dello stesso miniatore, il ms. Italien 81 della Bibliothèque nationale de France, un Dittamondo risalente all’incirca al decennio successivo: a c. 172v troviamo il leone, rappresentato all’interno di una serie di segni zodiacali, la cui figura risulta molto simile per il colore del manto, la forma della criniera e per un elemento singolare, ossia le striature della coda.
Note: Anche in questa miniatura, come a c. 6r, il protagonista ha le braccia alzate all’altezza del volto, ma stavolta tiene i pugni ben chiusi e la posa sembra voler suggerire una spinta in avanti. È plausibile che tale atteggiamento del protagonista indichi la lieve speranza dei vv. 37-43 di poter superare la prima belva, intuibile soprattutto dall’elemento dei pugni chiusi. L’identificazione della lonza con un leopardo è resa evidente dal particolare realismo con cui vengono rese le macule del mantello: tale interpretazione risulta coerente anche col commento di Barzizza, che identifica l’animale con «la femina del leon pardo».
c. 10v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante rovina dal colle spaventato dalle fiere.
Macrosoggetto: Tre fiere / Dante nella selva.
Parole chiave: alberi / fiume / selva / Dante / paura / rovinare / lupa / lonza / Leone / fiere / pianeta / Sole / rocce / colle / raggi luminosi.
Rapporto testo-immagine: Inferno I 31-60.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: Selva.
Rapporti con la tradizione dantesca: In pochi altri casi la fisicità della lupa è stata resa così minuziosamente: è il caso del Banco Rari 39, dove in realtà colpisce anche la posa dell’animale, identica a quella dell’It. 2017: entrambe le lupe, fameliche, sono intente a braccare Dante; si aggiungono a questo Oxford, Bodleian Library, Holkham misc. 48; Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga, S.C. 1162, Egerton 943.
Note: La raffigurazione della lupa dell’It. 2017 trova riscontro anche nel commento di Barzizza, che non solo definisce questo terzo impedimento «più forte che li altri», ma in realtà potrebbe proprio aver ispirato la raffigurazione del miniatore: egli, infatti, si sofferma a lungo sull’aspetto famelico dell’animale, il quale trova nell’esposizione morale il proprio riflesso nella descrizione – anch’essa molto corporale – dell’uomo avaro (cfr. G. Barzizza, Commento all'Inferno, a cura di F. Ruggiero, Roma, Salerno Editrice, 2022, p. 188).
c. 33v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio incontrano Caronte sulla riva del fiume Acheronte.
Macrosoggetto: Approdo di Caronte / Schiera degli ignavi.
Parole chiave: Dante / Virgilio / colloquio tra Dante e Virgilio / ignavi / vespe / mosconi / serpenti / sangue / anime dannate / riva / Acheronte / Caronte / barca.
Rapporto testo-immagine: Inferno III 64-129.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: Acheronte.
Rapporti con la tradizione dantesca: La rappresentazione di serpenti al posto di vermi come pena degli ignavi si ritrova anche in Holkham misc. 48 e It. 74.
Note: La scelta illustrativa dell’It. 2017 sembra coniugare le due versioni diametralmente opposte di Caronte che la tradizione iconografica offre: se in alcuni casi ci si sofferma di più sulla sua natura umana, di «vecchio», e in altri su quella di «dimonio», in questo codice la figura si presenta come un ibrido. Anche in altre raffigurazioni Caronte si presenta interamente coperto di pelo, ma nella maggior parte dei casi si tratta di un pelo scuro che serve a farne emergere la natura demoniaca; nel nostro, invece, il pelo bianco, pur non limitandosi solo alla barba e alla chioma, sembra calcare la mano sull’aspetto attempato che gli aveva conferito la tradizione classica, e in particolare virgiliana. L’attenzione mostrata dal miniatore per questa caratteristica può trovare plausibile riscontro nel commento: riprendendo Boccaccio, che si rifà a sua volta a Servio per l'associazione del nome Charon con Chronos, il commentatore identifica Caronte con il Tempo, associando al personaggio i tipici attributi della vecchiaia quali la canizie.
c. 39r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio invita Dante a discendere nel limbo.
Macrosoggetto: Limbo degli innocenti.
Parole chiave: Dante / Virgilio / Limbo / colloquio tra Dante e Virgilio / discesa / ingresso / Acheronte / rocce / pallore / fiume infernale.
Rapporto testo-immagine: Inferno IV 13-24.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: I cerchio - Limbo.
Note: Dante si avvicina all’ingresso della «valle d’abisso», che si trova più in basso rispetto al suolo, quasi come a visualizzare il «discendiàn» del v. 13, ossia il movimento inesorabile verso il basso che domina l’intera cantica. Nei versi il poeta parla proprio del «cieco mondo» in cui la vista non riesce a scorgere nient’altro che tenebra: tale sembra il luogo in cui il poeta latino si addentra, un’apertura nella roccia dipinta completamente di nero, a rappresentarne l’impenetrabilità. Confrontando il volto di Virgilio con quello raffigurato nelle altre carte, o anche con quello dello stesso Dante, sembra che il Magister abbia voluto rendere con un estremo grado di precisione l’aggettivo «smorto» del v. 14 e le parole di Dante ai vv. 16-18. Il colorito, infatti, che generalmente è reso dal miniatore con dei tocchi rosati sulle guance, è qui di un grigiore piatto che si uniforma al colore della barba. Con questa soluzione illustrativa il pallore di Virgilio si concretizza, creando un riferimento al testo ancora più diretto.
c. 59r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio davanti a Minosse.
Macrosoggetto: Davanti a Minosse.
Parole chiave: Dante / Virgilio / Minosse / anime dannate / coda.
Rapporto testo-immagine: Inferno V 1-24.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: II cerchio - Lussuriosi.
Note: Così come per Caronte, anche per il ritratto di Minosse il Magister Vitae Imperatorum sceglie una soluzione in grado di mediare tra i due estremi della tradizione iconografica: entrambi i personaggi mantengono una serie di tratti umani risalenti all’immagine che se ne aveva nella tradizione classica, ma vengono inesorabilmente deformati da attributi diabolici, irrevocabili per garantire l’adesione dell’apparato iconografico al testo. A differenza dei casi in cui Minosse avvolge la coda attorno a un dannato, nell’It. 2017, la coda compie tre giri intorno al suo addome, in una visualizzazione letterale dei vv. 11-12 «cignesi con la coda tante volte / quantunque gradi vuol che giù sia messa», che trova perfetto riscontro anche nel commento di Barzizza, il quale non lascia dubbi sul fatto che la coda sia avvolta attorno allo stesso Minosse piuttosto che all’anima condannata.
c. 63v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio incontrano le anime dei lussuriosi.
Macrosoggetto: Turba dei lussuriosi.
Parole chiave: Dante / Virgilio / colloquio tra Dante e Virgilio / lussuriosi / turba / Semiramide / Cleopatra / Elena / Didone / rocce / corona / regina / indicare / spiegazione.
Rapporto testo-immagine: Inferno V 31-69.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: II cerchio - Lussuriosi.
Note: Nella schiera dei lussuriosi, i primi quattro personaggi della fila hanno il capo coronato: si tratta senza dubbio delle quattro regine dell’antichità menzionate per prime da Virgilio. Tuttavia, le fattezze di uno di questi quattro spiriti non sembrano così inconfutabilmente femminili: le uniche caratteristiche che ha in comune con le tre donne vicine sono i capelli biondi e la corona; per il resto, i lineamenti risultano più marcati e spigolosi, quasi maschili, benché senza barba: tutto ciò rende piuttosto ambigua la sua figura se paragonata alle altre e più complessa l’identificazione. Volendo attenerci all’ordine seguito da Virgilio, tale personaggio dovrebbe essere Semiramide, regina assira condannata da Dante esclusivamente per il suo comportamento incestuoso. È il commento di Barzizza a fornire una panoramica molto più ampia sul personaggio, del quale si raccontano le notevoli doti strategiche: proprio nelle parole dell’esegeta si può trovare una plausibile spiegazione al fatto che il Magister la ritrae con fattezze quanto meno equivoche. Egli narra che, dopo la morte del marito Nino, Semiramide si ritrovò a dover mascherare la propria identità per poter prendere il potere: la regina finse, infatti, di essere suo figlio e governò da sovrano, assumendo un'identità maschile (cfr. Barzizza, Commento, cit., pp. 308-309). Si potrebbe, dunque, pensare che il miniatore abbia fornito ancora una volta una prova di grande minuzia nella rappresentazione, ma soprattutto che nella costruzione delle immagini non sia trascurabile l’apporto del commento di Barzizza, l’unico luogo nel codice dove effettivamente si tratta la questione dell’inganno della regina. Si veda: M. Castaldo, Rapporti testo-immagine nell'Inferno Parigi-Imola: casi di interazione tra miniature ed esegesi, in Rivista di Studi Danteschi, 2022/2, pp. 305-307.
c. 67r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio davanti a Francesca e Paolo.
Macrosoggetto: Avvicinamento di Francesca e Paolo.
Parole chiave: Dante / Virgilio / colloquio / Paolo e Francesca / Paolo Malatesta / Francesca da Polenta / turba / rocce / lussuriosi / angoscia / vento.
Rapporto testo-immagine: Inferno V 70-138.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: II cerchio - Lussuriosi.
c. 71v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante sviene dopo aver ascoltato la storia di Francesca e Paolo.
Macrosoggetto: Avvicinamento di Francesca e Paolo.
Parole chiave: Dante / Virgilio / svenimento / Paolo e Francesca / Paolo Malatesta / Francesca da Polenta / turba / lussuriosi / rocce / vento / angoscia.
Rapporto testo-immagine: Inferno V 139-142.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: II cerchio - Lussuriosi.
Rapporti con la tradizione dantesca: La perdita di sensi di Dante viene rappresentata piuttosto raramente nei manoscritti: Brieger cita soltanto l’Add. 19587 di Londra, lo Yates Thompson e il ms. It. 474 della Biblioteca Estense Universitaria di Modena, ai quali sembra doveroso aggiungere almeno il codice Filippino e l’It. IX. 276 di Venezia. In tutti questi codici, dunque, viene data rilevanza alla forte immagine con cui si chiude il canto V, benché sia possibile individuare delle sottili differenze nel modo in cui Dante viene ritratto. Se, infatti, nei mss. It. 2017, CF 2.16 e It. 474 egli è prono o completamente disteso a terra, evidenziando così il pathos del momento, nei restanti tre codici di questo campione, la sua posizione è piuttosto accovacciata (in Yat. Thomps. 36) oppure non del tutto distesa, ma obliqua, e ricorda in realtà lo stereotipo del Dante dormiente, soprattutto nell’Add. 19587.
c. 72r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio, in compagnia di Dante, getta una palla di terra nelle fauci di Cerbero che tormenta le anime dei golosi.
Macrosoggetto: Davanti a Cerbero.
Parole chiave: Dante / Virgilio / Cerbero / golosi / pioggia / fango / cane a tre teste / palla di terra / rocce / neve / paura / tormento / lanciare.
Rapporto testo-immagine: Inferno VI 1-33.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: III cerchio - Golosi.
Rapporti con la tradizione dantesca: Nonostante questo tipo di rappresentazione di Cerbero, che tiene in considerazione prima di tutto la fonte classica, non sia la più frequente nella tradizione iconografica, vi si allineano diversi codici: Strozzi 152, Urb. Lat. 365, Cha 597, Yat. Thomps 36, Add. 19587.
Note: L'immagine di Cerbero non subisce il tipico slittamento verso il demoniaco riscontrabile altrove nella tradizione iconografica: il Cerbero dell’It. 2017 rispetta fedelmente quello dell'Eneide e quello descritto da Barzizza. In effetti, l’esegeta quattrocentesco non aggiunge elementi anomali alla descrizione e quasi ogni volta che cita Cerbero vi aggiunge l’attributo «cane infernale», soffermandosi dunque a più riprese soltanto sulla sua natura canina. Il Magister Vitae Imperatorum si pone decisamente sulla stessa scia: Cerbero non ha qui caratteri antropomorfi né demoniaci, ma è un mastodontico cane a tre teste intento a torturare i dannati con le proprie zampe. Tra i tratti menzionati da Dante si possono ravvisare senza dubbio gli occhi vermigli e le zanne, ma non c’è traccia né del ventre largo – che, anzi, per la magrezza ricorda quello della lupa rappresentata nel I canto – né della barba, e le mani unghiate sonopiuttosto zampe canine, che insistono sugli sciagurati del terzo cerchio, provocandone probabilmente il sanguinamento, come sembra di scorgere da alcunemacchie rosse, distinguibili a fatica a causa del raschiamento della pergamena.
c. 82r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio, con Dante al suo fianco, si rivolge a Pluto.
Macrosoggetto: Pluto.
Parole chiave: Dante / Virgilio / Pluto / colloquio / rocce.
Rapporto testo-immagine: Inferno VII 1-15.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: IV cerchio - Avari e prodighi.
Rapporti con la tradizione dantesca: Si allineano alla raffigurazione di Pluto in veste diabolica: Add. 19587, tra le più simili a quella del nostro codice, a cui si aggiungono Bud; Estense; Holkham misc. 48; Canon. Ital. 108; Pal. 313; Plut. 40.7; CF 2.16; Triv. 2263; Madrid, BN, 10057.
Note: Le condizioni della pergamena, abrasa probabilmente per un intervento di censura, non consentono di dire molto sulla figura di Pluto: di questo demonio, infatti, si riescono a scorgere le estremità del corpo (ali, zampe artigliate, mani) e soltanto il disegno della sua figura. Tuttavia, a prima vista, la sua imponente figura si differenzia nettamente dai precedenti Caronte, Minosse, Cerbero: possiamo probabilmente affermare che nel Dante Parigi-Imola è questo il primo vero e proprio demonio con cui ci confrontiamo. Lo confermano non solo la sua mole, ma anche il fatto che la forma del corpo e delle mani sono gli unici attributi antropomorfi. Si guardi alle corna sul suo capo, alle ali da pipistrello, alle piccole fiamme che lo circondano, o alle grottesche zampe da capro: tutti questi elementi concorrono a dargli senza alcun dubbio un aspetto diabolico.
c. 84r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio mostra a Dante le schiere degli avari e dei prodighi / Avari e prodighi fanno rotolare i massi.
Macrosoggetto: Punizione degli avari e dei prodighi.
Parole chiave: colloquio tra Dante e Virgilio / Dante / Virgilio / avari / prodighi / rocce / massi / impronte / anime dannate / spiegare / urlare / rotolare / pietre / sassi / tormento.
Rapporto testo-immagine: Inferno VII 16-96.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: IV cerchio - Avari e prodighi.
Note: Nonostante la scarsa visibilità per l'abrasione della carta, in questa miniatura è ben evidente la resa minuziosa della ripetitività e della semicircolarità della danza dei dannati del IV cerchio, attraverso la rappresentazione delle impronte e della circonferenza che si spezza a metà. Un espediente molto particolare, presente anche in altre miniature del codice, consente, invece, di identificare ancora più precisamente avari e prodighi: il loro «ontoso metro» - «Perché tieni?» e «Perché burli?» del v. 30 - viene riportato nell’immagine, accanto alle figure rispettivamente dei prodighi, nel semicerchio in basso, e degli avari, in quello in alto, rendendo così possibile la distinzione in base alla frase pronunciata.
c. 102r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio parla con i diavoli della città di Dite mentre Dante si dispera / Virgilio torna verso Dante mentre i diavoli li sbeffeggiano dalle mura della città di Dite.
Macrosoggetto: Davanti alla città di Dite.
Parole chiave: Dante / Virgilio / città di Dite / porta / diavoli / Stige / palude Stigia / mura / angoscia / attesa / colloquio / roccia / fumo / sbeffeggiare / erba.
Rapporto testo-immagine: Inferno VIII 109-120.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: Città di Dite - burrato.
Note: La drammaticità dell'azione sembra acuita dalla contrapposizione tra il pallore di Dante e il colorito sanguigno di Virgilio. Nell’illustrazione il Magister non sorvola sugli aspetti patetici e regala all’osservatore un’immagine precisa dello stato d’animo del poeta: lo si deduce non solo dal volto esangue e dalla posa ricurva, ma soprattutto dall’inequivocabile atteggiamento delle mani, che sono intrecciate e tenute all’altezza dell’addome.
c. 111v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Arrivo del Messo celeste / Virgilio fa voltare Dante e gli copre gli occhi impedendogli la vista di Medusa.
Macrosoggetto: Davanti alla città di Dite.
Parole chiave: Dante / Virgilio / coprire gli occhi / palude Stigia / anime dannate / iracondi / aria / città di Dite / porta / mura / roccia.
Rapporto testo-immagine: Inferno IX 55-84.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: Città di Dite - burrato.
c. 114r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio visitano le tombe degli Epicurei.
Macrosoggetto: Avelli di Dite.
Parole chiave: Dante / Virgilio / avelli / fiamme / fuoco / rocce / eretici / tomba / colloquio tra Dante e Virgilio / Dante spaventato / confortare / spiegare.
Rapporto testo-immagine: Inferno IX 106-133.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VI cerchio - Eretici e Epicurei.
c. 119v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante parla con Farinata e Cavalcante mentre Virgilio attende in disparte.
Macrosoggetto: Avelli di Dite.
Parole chiave: Dante / Virgilio / colloquio / Farinata degli Uberti / Cavalcante de' Cavalcanti / avelli / eretici / roccia / mura / città di Dite / attesa / indicare / fiamme / Stige.
Rapporto testo-immagine: Inferno X 40-69.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VI cerchio - Eretici e Epicurei.
Rapporti con la tradizione dantesca: Il gesto di Dante, molto preciso nell'indicare Virgilio che lo attende in disparte, si ritrova anche in Eg 943.
c. 121r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante parla con Farinata e Cavalcante mentre Virgilio attende in disparte.
Macrosoggetto: Avelli di Dite.
Parole chiave: Dante / Virgilio / Farinata degli Uberti / Cavalcante de' Cavalcanti / avelli / eretici / fiamme / colloquio / mura / roccia / città di Dite / attesa / Stige.
Rapporto testo-immagine: Inferno X 73-120.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VI cerchio - Eretici e Epicurei.
c. 124v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio si incammina e Dante lo segue.
Macrosoggetto: Avelli di Dite.
Parole chiave: avelli / fiamme / Dante / Virgilio / camminare / mura / roccia / sentiero / alzare la mano.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VI cerchio - Eretici e Epicurei.
c. 134v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio davanti al Minotauro che si morde una mano dalla rabbia.
Macrosoggetto: Minotauro.
Parole chiave: Minotauro / mordersi la mano / Dante spaventato / Virgilio / rocce / pietra / frana.
Rapporto testo-immagine: Inferno XII 1-27.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VII cerchio - Violenti.
Rapporti con la tradizione dantesca: La raffigurazione del Minotauro come belva dal corpo animale e dalla testa umana è diffusa soprattutto nei codici della Commedia miniati del Trecento: tra i più simili Holkham misc. 48, Vat. Lat. 4776 e Pal. 313, in cui è riprodotto lo stesso gesto di mordersi la mano; nell'Estense e nell'Arsenal 8530 la figura è la stessa, ma la confusione coi centauri è tale che il Minotauro viene dotato di arco e frecce; ancora affini, nonostante la presenza delle corna, i mss. It. IX 276 e Ricc. 1035.
Note: L'iconografia del Minotauro del Parigi-Imola non si allinea del tutto a quella tradizionalmente quattrocentesca, in cui si recupera la figura classica del Minotauro dal corpo antropomorfo con testa taurina, ma si rifà piuttosto a quella più ampiamente diffusa nel Trecento nella tradizione iconografica della Commedia, in cui tale mostro presenta le due parti del corpo invertite: corpo animale e testa umana. Tale interpretazione viene rafforzata dalla lettura dell'esegesi: Barzizza non lascia dubbi al pubblico né al miniatore, specificando che il Minotauro «[…] dal peto in su era homo, lo resto era tauro […]» (Barzizza, Commento, cit., p. 477).
c. 147r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Nesso, con in groppa Dante e Virgilio, mostra le anime dei violenti immerse nel Flegetonte.
Macrosoggetto: Centauri e Flegetonte.
Parole chiave: Nesso / Dante / Virgilio / violenti contro il prossimo / Flegetonte / rocce / centauri / freccia / arco / fiume infernale / scortare / anime dannate.
Rapporto testo-immagine: Inferno XII 100-139.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: I girone - Violenti contro il prossimo.
Rapporti con la tradizione dantesca: La variante iconografica che vede Dante e Virgilio in groppa al centauro Nesso si trova anche in Chantilly 597, Altona, Strozzi 152, Yates Thompson 36, e nel Dante Eugeniano.
Note: L'immagine di Virgilio e Dante in groppa a Nesso si distacca dalle terzine dantesche, dal momento che solo Dante ha bisogno della scorta di Nesso per attraversare illeso il Flegetonte: si tratta di una deviazione dal testo presente anche in altra parte della tradizione iconografica. In questo caso, tuttavia, il risvolto più significativo della questione riguarda le modalità in cui questo errore possa essersi generato: benché non si tratti di un hapax iconografico, ma di una soluzione iconografica plausibilmente di natura poligenetica, sembra che nell’It. 2017 il commento di Barzizza possa aver fornito un apporto alla realizzazione di tale esito illustrativo. L’equivoco sarebbe nato principalmente dall’interpretazione del verso 114: il commentatore ritiene che Virgilio non stia parlando a Dante, ma al centauro Nesso, preannunciando che saranno entrambi a salire sul suo dorso equino per oltrepassare il fiume infernale. Si può ipotizzare, dunque, che le considerazioni del commentatore abbiano in qualche modo orientato in una direzione specifica gli esitiillustrativi; di conseguenza, potrebbero esserci buoni motivi per immaginare che Guiniforte Barzizza sia intervenuto in prima persona nell’ideazione dell’apparato decorativo del Dante Parigi-Imola. Nella miniatura a c. 147r quest’aspetto sembra ancora più manifesto, dal momento che l’immagine riporta un evidente errore ermeneutico in cui il nostro commentatore cade, dilungandosi persino in un’argomentazione dettagliata in cui prende le distanze dalla tradizione esegetica, alla quale pure si riallaccia in tutta la sua opera. (cfr. Barzizza, Commento, cit., p. 501 e M. Castaldo, Rapporti testo-immagine nell'Inferno Parigi-Imola, cit., pp. 307-309).
c. 160r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio osservano la fuga di Lano da Siena e le cagne che sbranano Iacopo di Sant’Andrea.
Macrosoggetto: Selva dei suicidi.
Parole chiave: Iacopo da Sant'Andrea / Lano da Siena / Dante / Virgilio / sbranare / cagne / selva dei suicidi / rami / alberi / sangue / fiume infernale / Flegetonte / fuggire / urlare / scialacquatori.
Rapporto testo-immagine: Inferno XIII 109-129.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: II girone - Violenti contro se stessi.
Note: Il miniatore si adopera nella rappresentazione dei «guai» menzionati al v. 22: accanto ad alcune fronde, in corrispondenza delle ferite sanguinanti, si leggono in inchiostro rosso i lamenti dei tormentati, resi tramite degli «hei» e «ha» di dolore. Si tratta indubbiamente di una soluzione molto originale, forse unica nella tradizione, tramite la quale si realizza un’esatta visualizzazione delle impressioni suscitate dai versi danteschi. Lo stesso accade per il grido «Or accorri, accorri, morte!» (v. 118) di Lano di Squarcia Maconi. .
c. 169r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio istruisce Dante sul Veglio di Creta e sull’origine dei fiumi infernali.
Macrosoggetto: Arrivo al sabbione infuocato.
Parole chiave: colloquio tra Dante e Virgilio / Virgilio / Dante / spiegare / selva dei suicidi / sabbione infuocato / violenti contro Dio / anime dannate / violenti / fiume infernale / Flegetonte / alberi / roccia / fuoco.
Rapporto testo-immagine: Inferno XIV 73-142.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: III girone - Violenti contro Dio, Natura, Arte.
Note: Ancora una volta il miniatore ricorre all’inserimento del discorso di un personaggio all’interno della vignetta. Le parole scaturiscono direttamente dalla bocca di Virgilio, rivolto verso Dante, seguendo un orientamento verticale. L’impressione che deriva dalla scelta del brano è un’enfatizzazione del momento pedagogico: in effetti, non si tratta, come altrove, della citazione di una breve battuta, bensì di una sezione scelta del testo, che si trascrive qui di seguito: «Tra tutto l’altro ch’io ti ho dimo / strato cossa non fu da li tuoi / occhi scorta notabile com’el / presente rio». Come si rileva dal confronto con le due terzine ai vv. 85-90, viene riportata per intero solo la proposizione principale del discorso di Virgilio, dunque i vv. 85, 88 e 89, tagliando così le subordinate ai vv. 86, 87 e 90: una selezione così accurata mira a rimarcare la parte fondamentale e più memorabile del discorso, oltre a tradire un plausibile intervento esterno nella scelta dei versi da riportare, forse proprio dello stesso Barzizza.
c. 185v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio parlano con l'anima di Iacopo Rusticucci che danza insieme a Tegghiaio Aldobrandi e Guido Guerra.
Macrosoggetto: Sodomiti.
Parole chiave: Guido Guerra / Tegghiaio Aldobrandi / Iacopo Rusticucci / Virgilio / Dante / tre sodomiti fiorentini / sodomiti / Flegetonte / danza / fiume infernale / colloquio / anime dannate / roccia.
Rapporto testo-immagine: Inferno XVI 1-90.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: III girone - Violenti contro Dio, Natura, Arte.
c. 191r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio lancia la corda dall'alto dirupo per richiamare Gerione.
Macrosoggetto: Gerione.
Parole chiave: Dante / Virgilio / lanciare / corda / burrato / sabbione infuocato / sodomiti / roccia / fiume infernale / Flegetonte / cascata / dirupo / sangue / fuoco.
Rapporto testo-immagine: Inferno XVI 91-117.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: III girone - Violenti contro Dio, Natura, Arte.
Rapporti con la tradizione dantesca: Il lancio della corda a Gerione è un soggetto iconografico piuttosto frequente nella tradizione miniata della Commedia: si ritrova in Yat. Thomps. 36, Eg 943, Urb. Lat. 365, Madrid, BN 10057, Canon. Ital. 108 – dove la corda, in base al riferimento di Dante ai vv. 107- 108, cattura in realtà una lupa identificata con la lussuria –, Vat. Lat. 4776.
c. 196r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio parla con Gerione mentre Dante incontra gli usurai.
Macrosoggetto: Gerione / Usurai.
Parole chiave: Gerione / Virgilio / Dante / usurai / parlare / Flegetonte / burrato / famiglia dei Gianfigliazzi / famiglia degli Obriachi / roccia / cascata / borse / Reginaldo Scrovegni / stemmi.
Rapporto testo-immagine: Inferno XVII 31-78.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: III girone - Violenti contro Dio, Natura, Arte.
Note: La meticolosità, inusitata rispetto ad altre descrizioni di creature infernali, che Dante impiega nella descrizione di Gerione avrà senza dubbio fornito all’artista un’ottima base per una rappresentazione quanto più particolareggiata possibile, soprattutto se si considera il grado di fedeltà al testo che egli sembra coerentemente seguire in tutto il codice, eccetto rari casi. Ciò non sembra affatto scontato, dal momento che la natura proteiforme di Gerione aveva suscitato non pochi problemi agli illustratori della Commedia, mettendo alla prova la loro capacità immaginifica. L’unico aspetto antropomorfo che Gerione conserva è la «faccia d’uom giusto» (v. 10), che il Magister Vitae Imperatorum sembra realizzare costantemente secondo un modello predefinito: anche qui a c. 196r, infatti, come nel caso di Chirone, si riscontra una forte somiglianza col volto di Virgilio, dovuta soprattutto alla capigliatura e alla folta barba, entrambe canute. Nessuno degli altri attributi fisici descritti da Dante (vv. 10-27) manca in questa mise en image: il corpo da serpente, dipinto di verde e decorato da variopinti «nodi e rotelle» (v. 15); le zampe pelose terminanti in lunghi artigli; la coda biforcuta da scorpione. Non sarà irrilevante, a tal proposito, notare che l’aderenza dell’immagine al testo è confermata anche dall’assenza di aggiunte indebite, che pure si riscontra in altra parte della tradizione iconografica. Inoltre, anche la posizione del mostro rispecchia quanto riportato nel testo: la testa e il busto sull’argine, la coda sospesa nel vuoto, secondo le similitudini dei «burchi» e del «bìvero» ai vv. 19-24.
c. 199r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio in groppa a Gerione discendono verso Malebolge, mentre osservano gli usurai.
Macrosoggetto: Gerione.
Parole chiave: Dante / Virgilio / Gerione / scortare / Flegetonte / usurai / sabbione infuocato / cascata / burrato / sangue / abbraccio / discesa / coda di scorpione / pallore / borse / stemmi.
Rapporto testo-immagine: Inferno XVII 79-117.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: III girone - Violenti contro Dio, Natura, Arte.
Note: Il Magister rappresenta esattamente la sequenza che si legge ai vv. 100-105, in cui Dante descrive il moto di Gerione, che, non possedendo ali, riesce a planare spostando l’aria con le zampe. Secondo Brieger, la discesa alle Malebolge del Parigi-Imola rientrerebbe, insieme a quella di Add. 19587, tra le più interessanti della tradizione (cfr. Brieger-Meiss-Singleton, cit., p. 138).
c. 204r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio in groppa a Gerione discendono verso Malebolge.
Macrosoggetto: Malebolge.
Parole chiave: Malebolge / ponte crollato / bolgia / discesa / Dante / Virgilio / scortare / discesa / roccia / pozzo / coda di scorpione / abbraccio.
Rapporto testo-immagine: Inferno XVIII 1-18.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VIII cerchio (Malebolge) - Fraudolenti.
Note: Benché non esplicitamente menzionato nei versi di riferimento, il Maestro delle Vitae Imperatorum illustra anche il ponte crollato tra le bolge sesta e settima:l’episodio concernente il disagevole passaggio ricorrerà nei canti XXIII e XXIV. Tuttavia, il fatto che questo particolare venga riportato già in questo punto del canto XVIII sembra piuttosto rilevante, dal momento che, appigliandosi ad altre parti del testo, contribuisce a fornire al lettore una chiara visione d’insieme di tutto il regno di Malebolge. Non è da escludere che questo dettaglio, ulteriore indizio di un considerevole grado di aderenza al testo, sia stato suggerito dal commento di Barzizza, in cui l’autore menziona proprio l’episodio del ponte crollato e la parte della cantica in cui se ne tratta (cfr. Barzizza, Commento, cit., p. 627).
c. 206v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante parla con Venedico Caccianemico mentre i diavoli tormentano i ruffiani e i seduttori.
Macrosoggetto: Ruffiani e seduttori.
Parole chiave: ruffiani / Venedico Caccianemico / diavoli / tormento / frustare / parlare / bolgia / Malebolge / roccia / ponte / coda di scorpione / ali di pipistrello.
Rapporto testo-immagine: Inferno XVIII 19-66.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: I bolgia - Ruffiani e seduttori.
c. 216r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio osservano incontrano gli adulatori nella seconda bolgia.
Macrosoggetto: Adulatori.
Parole chiave: bolgia / adulatori / Malebolge / Taide / Alessio Interminelli / tapparsi il naso / Dante / Virgilio / roccia / ponte / sterco / tormento / anime dannate.
Rapporto testo-immagine: Inferno XVIII 100-136.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: II bolgia - Adulatori e lusingatori.
c. 219r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante indica a Virgilio uno dei simoniaci.
Macrosoggetto: Simoniaci.
Parole chiave: simoniaci / bolgia / Malebolge / fiamme / pozzi / anime dannate / indicare / colloquio tra Dante e Virgilio / Dante / Virgilio / ponte / roccia / piedi.
Rapporto testo-immagine: Inferno XIX 7-39.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: III bolgia - Simoniaci.
Rapporti con la tradizione dantesca: Il Parigi-Imola è uno dei pochi codici in cui dei simoniaci non si scorge altro oltre i piedi e le caviglie, soluzione adottata in un’esigua parte della tradizione, ad esempio in Strozzi 152 e Plut. 90 inf. 42 .
Note: In merito alla rappresentazione dei vv. 22-24, che ha prodotto soluzioni iconografiche disparate in base all'interpretazione di «infin al grosso» (v. 24), è possibile che il commento abbia svolto un ruolo di mediazione tra la poesia di Dante e l’apparato illustrativo: è Barzizza, infatti, a specificare che i simoniaci si trovano piantati «col capo in giù fin ale polpe dele gambe», da intendere presumibilmente come se anche i polpacci fossero seppelliti nel foro.
c. 223r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante scende nella terza bolgia sulle spalle di Virgilio.
Macrosoggetto: Malebolge.
Parole chiave: bolgia / simoniaci / portare in braccio / scortare / Virgilio / Dante / indicare / ponte / roccia / fiamme / piedi / pozzi.
Rapporto testo-immagine: Inferno XIX 40-45.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: III bolgia - Simoniaci.
Note: Il miniatore sembra aver trovato, in questo soggetto e in quello della vignetta successiva, terreno fertile per sviluppare due motivi verso i quali si indirizza spesso la sua attenzione: le modalità in cui avviene il transito da una parte dell’Inferno all’altra e gli atteggiamenti fisici e patetici che più mettono in luce ilrapporto tra i due protagonisti. Nel canto XIX questi due fili si intrecciano perfettamente nell’immagine di Virgilio che aiuta Dante ad attraversare la terzabolgia porgendogli il proprio corpo come concreto supporto, scena che si ripete molto simile nella miniatura successiva. .
c. 230v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio porta in braccio Dante mentre si allontanano da Niccolò III.
Macrosoggetto: Simoniaci.
Parole chiave: portare in braccio / Virgilio / Dante / simoniaci / Malebolge / fiamme / pozzi / piedi / ponte / roccia / bolgia / anime dannate.
Rapporto testo-immagine: Inferno XIX 124-129.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: III bolgia - Simoniaci.
c. 245r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio guardano un diavolo che getta un barattiere nella pece.
Macrosoggetto: Incontro con i Malebranche.
Parole chiave: barattieri / diavoli / fiume di pece / uncini / anime dannate / graffiare / ponte / roccia / ali di pipistrello / Dante / Virgilio / raffio.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXI 25-57.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: V bolgia - Barattieri.
Note: Ritroviamo, a c. 245r, un altro “ritratto parlante”: viene riportata l’esclamazione del diavolo al v. 39, «Mettetel sotto, ch’io torno per anche», mentre rivolge una mano verso l’alto, come a indicare il luogo in cui ha appena annunciato di tornare .
c. 250v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio parla con i Malebranche mentre Dante si nasconde.
Macrosoggetto: Incontro con i Malebranche.
Parole chiave: Malebolge / Malebranche / barattieri / Malacoda / roccia / ponte / fiume di pece / nascondersi / parlare / diavoli / uncini / raffio / Dante / Virgilio.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXI 58-87.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: V bolgia - Barattieri.
Note: Tre dei quattro diavoli che figurano alle spalle di Malacoda presentano un’evidente affinità fisionomica, che li assimila tutti e tre a dei cani. Non si tratta di una semplice distorsione dei lineamenti, ma di una deformazione che vira in una direzione precisa e dota tali demoni di un muso inconfondibilmente canino; questa impressione è ulteriormente avallata dalle lingue che fuoriescono e, in un caso, dalle orecchie pendenti: il dettaglio serve evidentemente a mettere ancora più in contatto il lettore col testo dantesco. A Inf., XXI 67-68, infatti, il poeta si serve di una similitudine molto precisa, «Con quel furore e con quella tempesta / ch’escono i cani a dosso al poverello [...]», che plausibilmente giustifica la soluzione iconografica appena discussa .
c. 253r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante si avvicina a Virgilio mentre i Malebranche si offrono come scorta.
Macrosoggetto: Incontro con i Malebranche.
Parole chiave: scortare / Malebranche / Dante / Virgilio / parlare / diavoli / barattieri / Malebolge / bolgia / paura / uncini / raffio / ponte / roccia / fiume di pece.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXI 97-126.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: V bolgia - Barattieri.
Note: Qualche ipotesi di identificazione relativa alla folta schiera dei Malebranche: oltre a Malacoda, già comparso a c. 250v mentre era intento a parlare con Virgilio, solo un altro della schiera sembra individuabile con un certo margine di sicurezza. Si tratta di «Cerïatto sannuto» (v. 122), che è l’unico raffigurato con due acute zanne sporgenti, secondo la consueta assimilazione che, partendo dall’etimologia del nome, lo assocerebbe ad un maiale. Un’ulteriore conferma si trova nella miniatura a c. 259r, in cui si illustra il passaggio a Inf., XXII 55-58: Cerïatto, protagonista dell’attacco a Ciampolo di Navarra, è raffigurato esattamente come a c. 253r; anche in questo caso, il miniatore lo rende riconoscibile grazie ai denti, caratteristica peculiare ribadita in questi stessi versi dal poeta («E Cerïatto, a cui di bocca uscìa / d’ogni parte una sanna, come a porco […]»).
c. 255v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: I Malebranche guidano Dante e Virgilio.
Macrosoggetto: Incontro con i Malebranche.
Parole chiave: Malebranche / Dante / Virgilio / paura / Dante spaventato / diavoli / uncini / raffio / roccia / ponte / bolgia / trombetta / scortare / Barbariccia.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXI 127-139.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: V bolgia - Barattieri.
Rapporti con la tradizione dantesca: La rappresentazione del v. 139, «ed elli avea del cul fatto trombetta», ha talvolta messo in imbarazzo gli illustratori per la volgarità dell'immagine, mentre in questo caso fa quasi da protagonista della scena. Si tratta, dunque, di un soggetto iconografico piuttosto raro, che si ritrova in Altona e nel Pal. 313. .
c. 259r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio parlano con Ciampolo di Navarra, torturato dai Malebranche.
Macrosoggetto: Inganno di Ciampolo.
Parole chiave: Ciampolo di Navarra / Malebranche / Ciriatto / bolgia / Malebolge / barattieri / fiume di pece / diavoli / roccia / uncini / raffio / parlare / tormento / graffiare / Graffiacane / Rubicante / Barbariccia.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXII 31-75.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: V bolgia - Barattieri.
Note: La scrupolosa messa in scena degli atti dei Malebranche può risolvere in parte le difficoltà riscontrate in precedenza nell’individuazione dei singoli demoni. Il primo a prendere iniziativa è Graffiacane (vv. 34-36): la miniatura mostra chiaramente che la testa del barattiere di Navarra è trattenuta da un uncino, impugnato da un demonio dal corpo color ocra, con orecchie asinine e corna lisce. Ai vv. 37-42 interviene Rubicante, che infierisce con violenza contro l’anima malcapitata: questo passaggio viene reso con un grado di realismo più accentuato del solito, rendendo la scena molto cruenta. La schiena di Ciampolo è, infatti, completamente scuoiata a mani nude dal demonio e la resa è così particolareggiata che è possibile vedere il lembo di pelle scorticato, mentre il sangue che sgorga dalla ferita si mischia alla pece bollente in cui il barattiere era impaniato fino a poco prima. Anche in questo caso si può ricostruire l’identità del demonio: Rubicante sarà, dunque, identificabile nella figura dal corpo nero e la chioma bionda e riccia, a cui si aggiungono le consuete orecchie asinine e corna, mentre gli arti inferiori sono, come per Graffiacane, equini. Il demonio-cinghiale «Cerïatto, a cui di bocca uscìa / d’ogni parte una sanna, come a porco» (vv. 55-56), già individuato nelle carte precedenti per la sua peculiare dentatura, è a sua volta ritratto nel pieno dell’azione: mentre regge l’arpione con entrambe le mani, si scaglia contro il barattiere in un movimento che ricorda quello di un toro infuriato. Nel frattempo Barbariccia (vv. 59-60), raffigurato ancora con la coda a forma di corno, non serra Ciampolo tra le braccia, come recita il testo, ma è senz’altro evidente che si stia avventando, rabbioso, verso i suoi scalmanati compagni di bolgia, urlando loro contro per dare tregua al barattiere e permettere ai due pellegrini di conversare con lui. Un ultimo più incerto riferimento è a Libicocco (vv. 70-72), che amputa il braccio del navarrese: l'ipotesi è, in questo caso, meno sicura a causa di un intervento di rasura della pergamena. Se, tuttavia, non ci si inganna, pare che il demonio alle spalle di Graffiacane, a lui molto simile nelle fattezze, ma con corna e orecchie leggermente differenziate, brandisca il suo forcone proprio in direzione del navarrese, puntandolo dove plausibilmente il miniatore ne aveva illustrato il braccio, in un’area danneggiata dall’abrasione e dunque allo stato attuale scarsamente visibile.
c. 265v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio afferra Dante per sfuggire ai Malebranche.
Macrosoggetto: Fuga dai Malebranche.
Parole chiave: fuggire / portare in braccio / Malebolge / Malebranche / bolgia / diavoli / roccia / uncini / Dante / Virgilio / raffio.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXIII 34-57.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: V bolgia - Barattieri.
Rapporti con la tradizione dantesca: Brieger ha evidenziato le difficoltà degli illustratori nella trasposizione del passaggio alla sesta bolgia, precisando come solo raramente il movimento verticale dei due pellegrini, che precipitano lungo il pendio, sia stato visualizzato in maniera chiara: è il caso, oltre che del Parigi-Imola, dell'Additional. In molti altri casi ci si limita, invece, a rappresentare Virgilio tra le braccia di Dante; rappresentazioni più convincenti, al netto delle difficoltà già segnalate da Brieger, si trovano in Angelica 1102, Plut. 40.7, Strozzi 152 (cfr. Brieger-Meiss-Singleton, cit., p. 144).
c. 273r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Catalano dei Malavolti svela a Dante e Virgilio l'identità di Caifa, crocifisso per terra.
Macrosoggetto: Ipocriti.
Parole chiave: ipocriti / Catalano dei Malavolti / Caifa / Dante / Virgilio / spiegare / Loderingo degli Andalò / frati / cappe dorate / lacrime / anime dannate / tormento / crocifissione / bolgia / Malebolge / roccia / Dante / Virgilio / parlare.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXIII 109-126.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VI bolgia - Ipocriti.
c. 276v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio si arrampicano lungo l'argine della sesta bolgia per giungere alla settima.
Macrosoggetto: Scalata della bolgia.
Parole chiave: pietre / frana / ponte crollato / bolgia / Malebolge / Dante / Virgilio / portare in braccio / cappe dorate / ipocriti / roccia / lacrime / arrampicarsi.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXIV 22-36.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VI bolgia - Ipocriti.
Rapporti con la tradizione dantesca: Il Parigi-Imola si distingue per una soluzione unica nella raffigurazione della «ruina» che Dante e Virgilio adoperano per passare, probabilmente anche sulla scorta della descrizione dell'esegeta. L’impressione che generalmente viene fornita nella tradizione iconografica è quella di un’altura da scalare, certamente impervia, ma non costituita da pietre impilate l’una sull’altra, com'è nel caso qui in analisi. .
c. 277r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio giungono sul fondo della settima bolgia, dove assistono alla pena dei ladri.
Macrosoggetto: Metamorfosi dei ladri.
Parole chiave: Malebolge / bolgia / ladri / serpenti / anime dannate / tormento / ponte / roccia / Dante / Virgilio.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXIV 79-99.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VII bolgia - Ladri.
Note: La rappresentazione dei rettili che attaccano le anime dei ladri potrebbe aver risentito dell'influsso del commento di Barzizza: l'esegeta, infatti, non solo menziona la partizione della colpa e, rispettivamente, della pena dei ladri in tre categorie, ma si dilunga in una sorta di dissertazione zoologica che permetterebbe di distinguere le tipologie di serpenti citate da Dante («[…] chelidri, iaculi e faree / […] e cencri con anfisibena») attraverso una diversificazione iconografica inusitata, se non unica, nella tradizione. Guardando attentamente le miniature relative ai canti XXIV e XXV, sembra di poter riconoscere, negli animali raffigurati, alcune specifiche caratteristiche citate nel commento. Alcuni serpenti hanno, infatti, un corpo più piccolo ma rigonfio al centro e, a differenza degli altri, non si spostano con movimenti sinuosi: si potrebbe trattare dei chelidri. Sugli iaculi, d’altronde, è d’aiuto anche l’esposizione dei vv. 97-105, e difatti il serpente che attacca Vanni Fucci alla nuca sembra proprio trafiggerlo come una freccia. Ancora, sulle restanti specie, faree e cencri, è da notare che alcuni dei rettili sembrano effettivamente porsi di fronte ai dannati in una posizione semi-eretta, mentre altri ancora – che nella figura ricordano piuttosto dei draghi, essendo forniti di ali – non sono costretti a strisciare al suolo grazie alle loro zampe; quasi tutti, inoltre, eccetto quelli che si possono forse identificare con i chelidri, procedono con movimenti sinuosi e contorti. Infine, sull’anfisibena è forse possibile un’identificazione più certa: è evidente, infatti, nonostante sorgano alcune difficoltà per la rasura delle carte, come alcuni dei serpenti grigi raffigurati dal Magister siano dotati di due teste, il che è lampante soprattutto alle cc. 293r e 294r. Questo caso potrebbe avvalorare, dunque, l'ipotesi di un intervento diretto del commentatore nella costruzione dell'apparato iconografico del manoscritto. (cfr. Barzizza, Commento, cit., pp. 772-778 e M. Castaldo, Rapporti testo-immagine nell’Inferno Parigi-Imola, cit., pp. 310-312). .
c. 284r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio osservano Vanni Fucci avvolto da un serpente / Vanni Fucci mostra le "fiche" a Dio.
Macrosoggetto: Metamorfosi dei ladri.
Parole chiave: Vanni Fucci / serpenti / Dante / Virgilio / mostrare le fiche / gesti osceni / ladri / Malebolge / bolgia / roccia / ponte.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXV 1-9.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VII bolgia - Ladri.
Note: Se si guarda la figura di Vanni Fucci a c. 284r, è evidente che nei due pugni alzati al cielo, le “fiche” che egli rivolge a Dio sono due per mano: un tale dettaglio non sembra affatto casuale, e sarà da considerare sintomatico di un’interazione tra gli apparati esegetico e iconografico del codice. Difficile, infatti,pensare ad un’iniziativa personale dell’illustratore, dal momento che la meccanica del gesto ripropone esattamente quella descritta nel commento, in cui si legge: «Il ladro, al fine delle sue parole, recitate nel Canto precedente, alzò le mani con ambedue le fiche, per ciascuna mano, disprezzevolmente gridando: tolle Dio, che a te le squadro queste quattro fiche» (Barzizza, Commento, cit., p. 788). Il miniatore sembra, inoltre, aggravare la blasfemia del personaggio, riportando nella vignetta anche le parole pronunciate al verso 3. Leggiamo, quindi, dalla bocca di Vanni Fucci, «tolle Dio, ch’ad te le squadro» e, come nel caso dell’«accorri morte» a c. 160r, la scritta segue il moto della voce dell’anima disperata, che lancia il proprio grido verso l’alto (cfr. A. Mazzucchi, Le «fiche» di Vanni Fucci (‘Inf’., XXV 1-3). Il contributo dell'iconografia a una disputa recente, in «Rivista di studi danteschi», 1/2 (2001), pp. 302-315 e M. Castaldo, Rapporti testo-immagine nell'Inferno Parigi-Imola, cit., pp. 312-314.
c. 285v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio osservano il centauro Caco che si avvicina a Vanni Fucci.
Macrosoggetto: Metamorfosi dei ladri.
Parole chiave: Caco / centauro / serpenti / Dante / Virgilio / Malebolge / bolgia / roccia / ponte / ladri / anime dannate / fiamme / drago.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXV 16-24.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VII bolgia - Ladri.
Note: Come già evidenziato per altre miniature, anche a c. 285v, benché la scritta sia scolorita o forse soltanto abbozzata, viene riportata una delle battute più incisive della sezione testuale di riferimento: e, infatti, durante l’inseguimento di Vanni Fucci – probabilmente ancora presente sulla scena, più avanti nella schiera, tra i ladri che corrono – Caco grida «Ov’è? ov’è l’acerbo?» (v. 18), parole riportate accanto alla sua bocca.
c. 293r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio osservano la metamorfosi di Francesco dei Cavalcanti (il Guercio) e di Buoso Donati.
Macrosoggetto: Metamorfosi dei ladri.
Parole chiave: Francesco dei Cavalcanti (il Guercio) / Buoso Donati / Dante / Virgilio / metamorfosi / ladri / Malebolge / serpenti / fumo / coda / anime dannate / ponte / roccia.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXV 103-123.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VII bolgia - Ladri.
c. 294r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio osservano la metamorfosi di Francesco dei Cavalcanti (il Guercio) e di Buoso Donati.
Macrosoggetto: Metamorfosi dei ladri.
Parole chiave: Malebolge / bolgia / ladri / Dante / Virgilio / serpenti / anime dannate / Francesco dei Cavalcanti (il Guercio) / Buoso Donati / metamorfosi / ponte / roccia.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXV 121-135.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VII bolgia - Ladri.
c. 295r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio osservano la fine della metamorfodi di Buoso Donati e Francesco Cavalcanti e Dante riconosce Puccio Sciancato.
Macrosoggetto: Metamorfosi dei ladri.
Parole chiave: Buoso Donati / Francesco dei Cavalcanti (il Guercio) / Puccio Sciancato / metamorfosi / ladri / Malebolge / roccia / ponte / serpenti / sputare / anime dannate / Dante / Virgilio.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXV 136-151.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VII bolgia - Ladri.
c. 296v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio aiuta Dante nell'accesso all'ottava bolgia.
Macrosoggetto: Consiglieri fraudolenti.
Parole chiave: tenersi la mano / Dante / Virgilio / bolgia / salire / serpenti / arrampicarsi.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXVI 13-15.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VIII bolgia - Consiglieri fraudolenti.
c. 298r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio attraversano il ponte che conduce all'ottava bolgia.
Macrosoggetto: Consiglieri fraudolenti.
Parole chiave: ponte / arrampicarsi / Dante / Virgilio / Malebolge / bolgia / roccia.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXVI 16-18.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VIII bolgia - Consiglieri fraudolenti.
c. 298v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio incontrano Ulisse e Diomede.
Macrosoggetto: Consiglieri fraudolenti.
Parole chiave: Malebolge / consiglieri fraudolenti / Ulisse / Diomede / fiamme biforcute / anime dannate / Dante / Virgilio / parlare / indicare / ponte / bolgia.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXVI 43-142.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: VIII bolgia - Consiglieri fraudolenti.
Rapporti con la tradizione dantesca: La variante iconografica per cui le fiamme che avvolgono i consiglieri fraudolenti non ne nascondono i volti, come vorrebbe il testo dantesco, è piuttosto diffusa nella tradizione: ai manoscritti citati da Brieger,. che evidenzia come si tratti di una tendenza quattrocentesca (Parigi-Imola, Holkham misc. 48, Plut. 40.7, Altona, Cha 597), si possono aggiungere almeno i casi di Yat. Thomps. 36, It. IX 276, Vat. Lat. 4776, Plut. 40.1, ms. 67 di Padova, Bud, CF 2.16, in cui i dannati compaiono a figura intera; Arsenal 8530 e Madrid BN 10057, in cui si vede solo parte del busto; infine, il ms. It. 74, in cui, come nel nostro caso, dei consiglieri fraudolenti si scorgono soltanto i volti. (cfr. Brieger-Meiss-Singleton, cit., p. 148).
c. 313r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio incontrano i seminatori di discordia.
Macrosoggetto: Seminatori di discordia.
Parole chiave: Malebolge / bolgia / seminatori di discordia / anime dannate / diavolo / spada / ponte / parlare / Dante / Virgilio / Maometto / Bertrand de Born / Alì / Pier da Medicina / Curione / Mosca dei Lamberti.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXVIII 1-142.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: IX bolgia - Seminatori di discordia.
Rapporti con la tradizione dantesca: La modalità rappresentativa dei seminatori di discordia più simile a quella del Parigi-Imola si trova in Angelica 1102: difatti, anche qui in una sola vignetta si convogliano tutte e sei le anime offese dalla spada del demonio che Dante nomina; esse, come nell’It. 2017, sono disposte in una fila che rispetta l’ordine di apparizione, oltre che rese singolarmente identificabili dal tipo di ferita.
Note: A c. 313bisr è possibile visualizzare a colpo d’occhio e identificare tutti i seminatori di discordia incontrati da Dante nella nona bolgia, nonché il demonio che li tortura: come in buona parte della tradizione miniata, le sei anime che si presentano esplicitamente all’autore vengono rese riconoscibili dalle loro diverse ferite, restituite con fedeltà e, nel caso specifico, rappresentati anche in ordine di apparizione nel canto. A questi personaggi il Magister Vitae Imperatorum aggiunge altre due figure, evidentemente anonime. Parte delle parole del profeta islamico Alì vengono riportate nella vignetta: in maniera abbastanza coerente con quanto già osservato nei casi simili dello stesso codice, si tratta di una delle esclamazioni evidentemente tese a restare impresse nella mente dell’osservatore. Il miniatore, o chi per lui ha realizzato le scritture esposte, riporta, infatti, «Vedi como scipato è Machometo», che corrisponde nel testo al verso 31.
c. 327v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante parla con Griffolino d'Arezzo e Capocchio.
Macrosoggetto: Falsari.
Parole chiave: Malebolge / bolgia / ponte / falsari / Griffolino d'Arezzo / Capocchio / puzza / Dante / Virgilio / parlare / grattarsi / roccia / ferite / sangue / scabbia.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXIX 73-139.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: X bolgia - Falsari.
c. 332r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio guardano Gianni Schicchi che morde il collo di Capocchio e Mirra in fuga.
Macrosoggetto: Falsari.
Parole chiave: Malebolge / bolgia / falsari / Dante / Virgilio / Capocchio / Gianni Schicchi / Mirra / mordere / ponte / roccia / puzza / anime dannate / fuggire.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXX 25-48.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: X bolgia - Falsari.
c. 335v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio incontrano Mastro Adamo, Sinone e la moglie di Putifarre.
Macrosoggetto: Falsari.
Parole chiave: Dante / Virgilio / parlare / Mastro Adamo / Sinone / moglie di Putifarre / Malebolge / bolgia / puzza / ponte / roccia / strapparsi i capelli.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXX 46-99.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: X bolgia - Falsari.
c. 359r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio mostra a Dante i giganti nel pozzo.
Macrosoggetto: Giganti.
Parole chiave: Dante / Virgilio / pozzo / Giganti / Fialte / Anteo / catene / roccia.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXXI 82-111.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: Pozzo dei giganti.
Note: Dante e Virgilio danno, curiosamente, le spalle all’osservatore soluzione unica all’interno del codice, e, in generale, molto rara nella tradizione miniata. Possiamo immaginare che negli intenti dell’artista ci fosse la raffigurazione del movimento antiorario che Dante e Virgilio, «vòlti a sinistra» (v. 83), compiono percorrendo in tondo l’argine del pozzo: tale ragionamento sembra concordare anche con la posizione dei protagonisti nella miniatura successiva, a c. 361r, dove essi, dopo aver proseguito ancora lungo la circonferenza verso sinistra, si trovano di fronte ad Anteo.
c. 361r

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Virgilio parla con Anteo.
Macrosoggetto: Giganti.
Parole chiave: pozzo / Anteo / Dante / Virgilio / parlare / Giganti / Fialte / scortare / roccia / catene.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXXI 112-129.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: Pozzo dei giganti.
c. 361v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Anteo trasporta Dante e Virgilio sul fondo della ghiaccia di Cocito.
Macrosoggetto: Discesa in Cocito.
Parole chiave: Cocito / lago ghiacciato / Anteo / discesa.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXXII.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: IX cerchio - Traditori.
c. 370v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio parlano con il conte Ugolino che rode il capo dell'arcivescovo Ruggieri.
Macrosoggetto: Ugolino e Ruggieri.
Parole chiave: Antenora / Cocito / traditori / Ugolino della Gherardesca / Ruggieri degli Ubaldini / rodere il capo / Dante / Virgilio / parlare / lago ghiacciato / anime dannate / sangue.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXXII 124-139.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: II zona (Antenora) - Traditori della patria.
c. 371v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio parlano con Ugolino.
Macrosoggetto: Ugolino e Ruggieri.
Parole chiave: alzare la testa / Dante / Virgilio / parlare / anime dannate / traditori / Antenora / Ugolino della Gherardesca / Ruggieri degli Ubaldini / lago ghiacciato / Cocito / sangue.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXXIII 1-78.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: II zona (Antenora) - Traditori della patria.
Note: La vignetta che introduce il canto XXXIII non può essere adeguatamente discussa se non considerata come parte di una coppia iconografica, formata dalle miniature alle cc. 370v e 371v. Com’è evidente, esse risultano non solo successive dal punto di vista cronologico, ma anche poste in due carte adiacenti: per l’osservatore, ciò rende il cambio di scena ancora più repentino, poiché avviene semplicemente sfogliando una pagina. Per come sono concepite, le due miniature ricordano molto da vicino parte del ciclo realizzato per il canto I, dove ad una serie di scene sostanzialmente uguali, il miniatore aggiunge di volta in volta la nuova fiera che si presenta a Dante nella selva, lasciando il resto dell’immagine immutata. Lo stesso accade qui alle cc. 370v e 371v: la componente principale da cui si deduce la modalità di lavoro del Magister Vitae Imperatorum è lo sfondo del Cocito, che in entrambe le miniature accoglie le anime dei traditori, immobilizzate dal ghiaccio, in pose esattamente identiche. Il solo fattore di rilievo, che costituisce il fulcro diegetico della scena nonché l’unico elemento di differenziazione tra le due vignette, consiste nel movimento di Ugolino, che, finalmente distolto dalla propria preda, alza il capo guardando Dante e Virgilio. È chiaro, dunque, che il principale riferimento sarà il noto verso che apre il canto XXXIII, «La bocca sollevò dal fiero pasto». Ciò che più meraviglia è che l’impressione che Dante, in poesia, regala al movimento di Ugolino, aprendo il canto XXXIII con un verso così incisivo, sembra tradotta perfettamente nell’illustrazione proprio grazie al rapporto che si instaura tra le due carte adiacenti.
c. 379v

Tipologia: Incorniciata, nella colonna di testo.
Tecnica esecutiva: tempera, con presenza di oro.
Soggetto: Dante e Virgilio osservano Lucifero che maciulla Giuda, Bruto e Cassio.
Macrosoggetto: Lucifero.
Parole chiave: Dante / Virgilio / colloquio tra Dante e Virgilio / spiegare / Lucifero / Giudecca / Lucifero / Cocito / lago ghiacciato / ali di pipistrello.
Rapporto testo-immagine: Inferno XXXIV 1-69.
Livello del testo: storie prime.
Contesto interno: Lucifero.
Note: I pochi elementi della figura di Lucifero individuabili con certezza, che rispecchiano adeguatamente il testo dantesco, sono la spaventosa mole e le tre coppie di ali da pipistrello; in maniera più dubbia, invece, sembra si possa scorgere un braccio, coronato da una zampa artigliata che porta alla bocca, probabilmente intento a maciullare uno dei tre grandi peccatori della Giudecca, nonché una serie di tratti ondulati con cui si cerca forse di rendere il corpo irsuto. Le condizioni della pergamena, completamente abrasa in corrispondenza della figura di Lucifero, non consentono di avanzare ipotesi più certe a riguardo.
Stemma: C. C. 82v, Visconti, Milano. C. 97r , Visconti, Milano.
Bibliografia
Bibliografia manoscritto: Auvray 1892, pp. 115-127 e pp. 170-175; Morel 1896; Brieger/Meiss/Singleton 1969, pp. 38-39 e pp. 319-321; Roddewig 1984, pp. 248 n. 574; Censimento I, t. II, p. 969-970 n. 564; Ruggiero 2022.
Autore/i della scheda (sezione MOL): Federico Ruggiero, Maria Castaldo
Autore/i della scheda (sezione IDP): Maria Castaldo